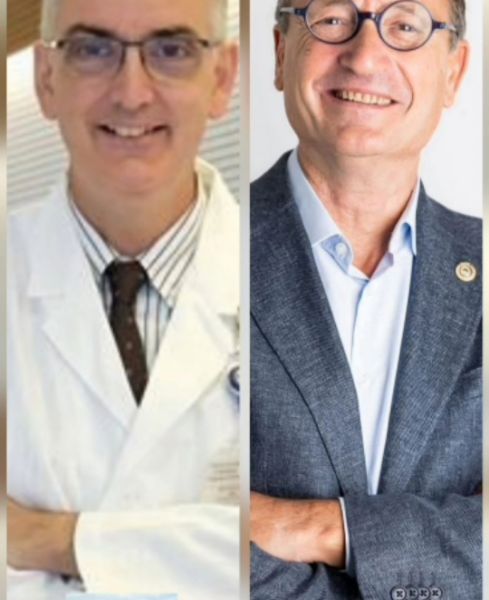Oggi affrontiamo il tema del ritratto. Questa mostra con le opere dal museo di Toledo contiene infatti alcuni ritratti molto belli, che discendono da Matisse e Hopper – in questo caso entro una ambientazione teatrale che amplia il discorso sul volto e sullo sguardo e lo situa nella prospettiva di figure nel bozzolo di un assoluto – fino a Manet e Degas. Matisse, nel suo Danzatrice a riposo, che è propriamente un’apparizione, una farfalla un attimo posata, risolve ogni cosa dentro un clima di vividezza e pacata sensualità tutta rilasciata nello spazio di una stanza. Negli stessi anni in cui Matisse e Picasso designano in Europa un nuovo modo di essere pittori, Edward Hopper in America si pone alla conclusione di un viaggio ottocentesco della pittura d’oltre oceano. Il quadro meraviglioso in mostra del museo di Toledo ne è sintesi perfetta. Hopper inventa una luce che presenta e si presenta, oggetto medesimo del racconto, anzi più di tutto oggetto di quel dire con il colore. La luce che genera un corto circuito, che accenna al mistero dell’apparizione delle cose e della loro sparizione. La presenza e l’assenza del mondo si sommano dentro il potere miracoloso e segreto della luce. Negli stessi anni in cui Matisse e Picasso designano in Europa un nuovo modo di essere pittori, Edward Hopper in America si pone alla conclusione di un viaggio ottocentesco della pittura d’oltre oceano. Il quadro meraviglioso in mostra del museo di Toledo ne è sintesi perfetta. Hopper inventa una luce che presenta e si presenta, oggetto medesimo del racconto, anzi più di tutto oggetto di quel dire con il colore. La luce che genera un corto circuito, che accenna al mistero dell’apparizione delle cose e della loro sparizione. La presenza e l’assenza del mondo si sommano dentro il potere miracoloso e segreto della luce. Se il processo del comporre il quadro in Matisse scompare in nome della tensione armonizzante, in Picasso quel processo diventa invece “argomento” per il quadro, per il ritratto. La contemporanea presenza nel suo cubismo di forma e spazio, l’annullamento della seconda e della terza dimensione, tutto giocava a favore della rappresentazione simultanea di prospettive le più diverse. Come vediamo benissimo nel quadro in mostra, Donna con il cappello nero, si trattava di scoprire il volto di una persona, una parte del suo stesso corpo, attraverso percorsi. Indovinarne lo sguardo sotto il sontuoso cappello con la piuma. Ma in questo senso il processo creativo portava a una nuova pittura di ritratto, che poco aveva a che fare con la sola somiglianza. Se il processo del comporre il quadro in Matisse scompare in nome della tensione armonizzante, in Picasso quel processo diventa invece “argomento” per il quadro, per il ritratto. La contemporanea presenza nel suo cubismo di forma e spazio, l’annullamento della seconda e della terza dimensione, tutto giocava a favore della rappresentazione simultanea di prospettive le più diverse. Come vediamo benissimo nel quadro in mostra, Donna con il cappello nero, si trattava di scoprire il volto di una persona, una parte del suo stesso corpo, attraverso percorsi. Indovinarne lo sguardo sotto il sontuoso cappello con la piuma. Ma in questo senso il processo creativo portava a una nuova pittura di ritratto, che poco aveva a che fare con la sola somiglianza. In quegli anni parigini, di piena vitalità, Amedeo Modigliani incarna la figura di un ritrattista incline al ripiegamento interiore, frutto di una malinconia che appare quasi senza soluzioni e che fa dell’accadimento individuale una possibilità di riscatto. Volti come sigle, nell’unicità di uno stile pittorico che non ha eguali, come si vede nel ritratto di Paul Guillaume in mostra. Attratto dalla pittura italiana trecentesca, ma ben consapevole delle novità introdotte sulla linea Cezanne/Picasso, egli diede un contributo fuori dal comune nell’evoluzione del concetto di ritratto. Facendo della secchezza, della semplicità segnata da una linea che proveniva anche dalla scultura, il timbro indelebile e si direbbe definitivo. In quegli anni parigini, di piena vitalità, Amedeo Modigliani incarna la figura di un ritrattista incline al ripiegamento interiore, frutto di una malinconia che appare quasi senza soluzioni e che fa dell’accadimento individuale una possibilità di riscatto. Volti come sigle, nell’unicità di uno stile pittorico che non ha eguali, come si vede nel ritratto di Paul Guillaume in mostra. Attratto dalla pittura italiana trecentesca, ma ben consapevole delle novità introdotte sulla linea Cezanne/Picasso, egli diede un contributo fuori dal comune nell’evoluzione del concetto di ritratto. Facendo della secchezza, della semplicità segnata da una linea che proveniva anche dalla scultura, il timbro indelebile e si direbbe definitivo. E poi la presenza in mostra di significativi ritratti di autori legati al tempo impressionista, Manet, Degas e Renoir. Il senso dello sguardo intimo, e dunque dell’intimità del ritratto – si veda per esempio il meraviglioso Victoria Dubourg di Degas in esposizione –, sono centrali nella visione di Monet e compagni. Destinando la propria attenzione a modelli a loro vicini – lo stesso Antonin Proust di Manet sempre in mostra –, in luoghi della usuale frequentazione quotidiana, si trovarono a sviluppare dipinti che si affacciavano senza sosta sull’esistenza di ogni giorno. Dipingevano da una finestra che era la loro vita e si sbarazzavano delle convenzioni secondo i canoni della ritrattistica tradizionale. E poi la presenza in mostra di significativi ritratti di autori legati al tempo impressionista, Manet, Degas e Renoir. Il senso dello sguardo intimo, e dunque dell’intimità del ritratto – si veda per esempio il meraviglioso Victoria Dubourg di Degas in esposizione –, sono centrali nella visione di Monet e compagni. Destinando la propria attenzione a modelli a loro vicini – lo stesso Antonin Proust di Manet sempre in mostra –, in luoghi della usuale frequentazione quotidiana, si trovarono a sviluppare dipinti che si affacciavano senza sosta sull’esistenza di ogni giorno. Dipingevano da una finestra che era la loro vita e si sbarazzavano delle convenzioni secondo i canoni della ritrattistica tradizionale. |

 Negli stessi anni in cui Matisse e Picasso designano in Europa un nuovo modo di essere pittori, Edward Hopper in America si pone alla conclusione di un viaggio ottocentesco della pittura d’oltre oceano. Il quadro meraviglioso in mostra del museo di Toledo ne è sintesi perfetta. Hopper inventa una luce che presenta e si presenta, oggetto medesimo del racconto, anzi più di tutto oggetto di quel dire con il colore. La luce che genera un corto circuito, che accenna al mistero dell’apparizione delle cose e della loro sparizione. La presenza e l’assenza del mondo si sommano dentro il potere miracoloso e segreto della luce.
Negli stessi anni in cui Matisse e Picasso designano in Europa un nuovo modo di essere pittori, Edward Hopper in America si pone alla conclusione di un viaggio ottocentesco della pittura d’oltre oceano. Il quadro meraviglioso in mostra del museo di Toledo ne è sintesi perfetta. Hopper inventa una luce che presenta e si presenta, oggetto medesimo del racconto, anzi più di tutto oggetto di quel dire con il colore. La luce che genera un corto circuito, che accenna al mistero dell’apparizione delle cose e della loro sparizione. La presenza e l’assenza del mondo si sommano dentro il potere miracoloso e segreto della luce. Se il processo del comporre il quadro in Matisse scompare in nome della tensione armonizzante, in Picasso quel processo diventa invece “argomento” per il quadro, per il ritratto. La contemporanea presenza nel suo cubismo di forma e spazio, l’annullamento della seconda e della terza dimensione, tutto giocava a favore della rappresentazione simultanea di prospettive le più diverse. Come vediamo benissimo nel quadro in mostra, Donna con il cappello nero, si trattava di scoprire il volto di una persona, una parte del suo stesso corpo, attraverso percorsi. Indovinarne lo sguardo sotto il sontuoso cappello con la piuma. Ma in questo senso il processo creativo portava a una nuova pittura di ritratto, che poco aveva a che fare con la sola somiglianza.
Se il processo del comporre il quadro in Matisse scompare in nome della tensione armonizzante, in Picasso quel processo diventa invece “argomento” per il quadro, per il ritratto. La contemporanea presenza nel suo cubismo di forma e spazio, l’annullamento della seconda e della terza dimensione, tutto giocava a favore della rappresentazione simultanea di prospettive le più diverse. Come vediamo benissimo nel quadro in mostra, Donna con il cappello nero, si trattava di scoprire il volto di una persona, una parte del suo stesso corpo, attraverso percorsi. Indovinarne lo sguardo sotto il sontuoso cappello con la piuma. Ma in questo senso il processo creativo portava a una nuova pittura di ritratto, che poco aveva a che fare con la sola somiglianza. In quegli anni parigini, di piena vitalità, Amedeo Modigliani incarna la figura di un ritrattista incline al ripiegamento interiore, frutto di una malinconia che appare quasi senza soluzioni e che fa dell’accadimento individuale una possibilità di riscatto. Volti come sigle, nell’unicità di uno stile pittorico che non ha eguali, come si vede nel ritratto di Paul Guillaume in mostra. Attratto dalla pittura italiana trecentesca, ma ben consapevole delle novità introdotte sulla linea Cezanne/Picasso, egli diede un contributo fuori dal comune nell’evoluzione del concetto di ritratto. Facendo della secchezza, della semplicità segnata da una linea che proveniva anche dalla scultura, il timbro indelebile e si direbbe definitivo.
In quegli anni parigini, di piena vitalità, Amedeo Modigliani incarna la figura di un ritrattista incline al ripiegamento interiore, frutto di una malinconia che appare quasi senza soluzioni e che fa dell’accadimento individuale una possibilità di riscatto. Volti come sigle, nell’unicità di uno stile pittorico che non ha eguali, come si vede nel ritratto di Paul Guillaume in mostra. Attratto dalla pittura italiana trecentesca, ma ben consapevole delle novità introdotte sulla linea Cezanne/Picasso, egli diede un contributo fuori dal comune nell’evoluzione del concetto di ritratto. Facendo della secchezza, della semplicità segnata da una linea che proveniva anche dalla scultura, il timbro indelebile e si direbbe definitivo. E poi la presenza in mostra di significativi ritratti di autori legati al tempo impressionista, Manet, Degas e Renoir. Il senso dello sguardo intimo, e dunque dell’intimità del ritratto – si veda per esempio il meraviglioso Victoria Dubourg di Degas in esposizione –, sono centrali nella visione di Monet e compagni. Destinando la propria attenzione a modelli a loro vicini – lo stesso Antonin Proust di Manet sempre in mostra –, in luoghi della usuale frequentazione quotidiana, si trovarono a sviluppare dipinti che si affacciavano senza sosta sull’esistenza di ogni giorno. Dipingevano da una finestra che era la loro vita e si sbarazzavano delle convenzioni secondo i canoni della ritrattistica tradizionale.
E poi la presenza in mostra di significativi ritratti di autori legati al tempo impressionista, Manet, Degas e Renoir. Il senso dello sguardo intimo, e dunque dell’intimità del ritratto – si veda per esempio il meraviglioso Victoria Dubourg di Degas in esposizione –, sono centrali nella visione di Monet e compagni. Destinando la propria attenzione a modelli a loro vicini – lo stesso Antonin Proust di Manet sempre in mostra –, in luoghi della usuale frequentazione quotidiana, si trovarono a sviluppare dipinti che si affacciavano senza sosta sull’esistenza di ogni giorno. Dipingevano da una finestra che era la loro vita e si sbarazzavano delle convenzioni secondo i canoni della ritrattistica tradizionale.